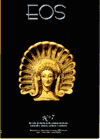|
Anno 3 - N. 8 / 2004
IMMAGINI E LETTERATURA
“La pittura, l’unica forma espressiva che comprende
nello stesso momento il suo incipit e la sua conclusione?”
L’ekfrasi di Pierre Micron
di Samanta Learda

Lo sbarco di Cleopatra a Tarso (1642-43)
Claude Lorrain (Chamagne, 1600-Roma, 1682)
Parigi, Museo del Louvre
Un dipinto comunica l’immagine di un mondo che può non appartenerci, ma di cui percepiamo gli orizzonti: il messaggio si esaurisce in un unico campo immaginifico che viene colto in modo immediato creando un coinvolgimento emotivo tale da rispondere all’immediatezza con un giudizio dettato esclusivamente dalla sensibilità individuale. Nasce, al contempo, nel fruitore, la necessità di un approfondimento analitico, discorsivo e, in definitiva, storico del quadro preso in considerazione. Solitamente la descrizione di un’opera visiva si limita ad un’asciutta e rapida analisi critica; procedimento più complesso è, invece, il tradurre un dipinto in un testo scritto, perché significa porsi come mediatore tra l’attimo d’intuizione e l’analisi descrittiva dell’opera, avvicinando il lettore dapprima al processo discorsivo e analitico per arrivare quindi alla visualizzazione della totalità dell’immagine.
Questo tipo di procedimento è noto in letteratura con il nome di ekfrasi: usato molto spesso in epoca classica, lo si ritrova in un testo di un autore francese contemporaneo, Pierre Michon, edito da Verdier nel 1996.
Il racconto, scritto in prima persona, è ambientato nella campagna romana del Seicento e narra le vicende di Gian Domenico Desideri che da semplice pastore si trasformerà, per un caso fortuito, in pittore appartenente alla scuola romana voluta e fondata da Papa Urbano XIII Barberini. Accortosi, poi, della vanità e dell’inutilità di quel mondo, ne supera i limitati orizzonti e riafferma se stesso diventando cacciatore a servizio dei Gonzaga in una Mantova che “sa di fango”, dove si costruirà un suo regno; di qui il titolo: “Le Roi du bois”. La tecnica è quella dell’io narrante, una sorta di biografia fittizia che trova le sue radici nelle uniche notizie storicamente accertate sull’esistenza di Gian Domenico Desiderii le quali riportano che tra il 1630 e il 1650 fu allievo di Claude Lorrain, pittore che influenzerà, assieme a Nicolas Poussin, la pittura di paesaggio. Infatti in questo periodo la scuola pittorica romana sviluppa un nuovo sentimento della natura attraverso la rievocazione di un mondo popolato di figure mitologiche e storiche tra rovine classiche ed ambientazioni fantastiche; e la campagna romana con il suo territorio ricco di boschi, rocce tufacee e corsi d’acqua fornisce l’archetipo adeguato a questo genere pittorico. Michon, non a caso, immagina Gian Domenico nelle vesti di pastore, inserito in un’ambientazione arcadica nella Tivoli del diciassettesimo secolo ricca di immagini bucoliche: “les mèmes arbres, les mèmes bergeries, les mèmes palais quand le soleil se lève et le ciel à-dessous comme un trou” (“gli stessi alberi, gli stessi pascoli, gli stessi palazzi alla luce dell’alba e il cielo lassù come un buco”), dove si rende evidente l’inconsapevole appartenenza del protagonista a quel paesaggio dipinto in cui vive immerso tra le diverse tonalità di verde, accanto alle pecore e ai grandi alberi. Michon, dunque, dà voce, restituisce movimento al quadro in cui Gian Domenico stesso si colloca, dando forza alle parole come un pittore stende i colori a strati spessi: gli alberi stormiscono, le cascatelle scrosciano, le pecore sonnecchiano al rezzo. La sua scrittura tratteggia come un pennello figure che risaltano sullo sfondo del verde dei boschi e nel gioco dei chiaroscuri come macchie di colore: l’intensità dell’azzurro copre le vesti delle nobildonne, tinge i cieli esageratamente spaziosi; la potenza del rosso riveste la tunica dei Monsignori. I colori, catalizzatori della metafora, esprimono la loro caratura attraverso immagini contrapposte e, in certa misura contraddittorie: l’azzurro riveste l’erotismo delle giovani donne compiacenti, ma rappresenta anche la sacralità del manto della Madonna; lo stesso vale per il rosso che è metafora per antonomasia della passione e che tinge, nel contempo, le vesti talari dei Monsignori; solo il giallo si svincola dalla dialettica della contraddizione ed univocamente restituisce l’immagine del blasonato stemma dei Barberini, dell’oro, del potere. L’autore pare ammiccare, pare voler comunicare al lettore di non fermarsi alle apparenze, di andare oltre l’immagine del dipinto per vedere che cosa si nasconde dietro e anche se è consapevole che dietro al quadro non c’è nulla, preferisce farsi latore dell’unica realtà possibile piuttosto che continuare a guardare il quadro illudendosi che sia vero. Infatti quando Gian Domenico da dipinto diventa pittore, più per caso che per scelta, capisce ben presto di essere fuori posto e non potendo più raggiungere quella natura, quella campagna romana che ha abbandonato nel momento in cui ha cambiato status, sceglie in piena coscienza di rifugiarsi nei boschi, non più da bucolico pastore ma come cacciatore spietato. È come se la tela fosse stata lacerata da uno squarcio: lo sfondo arcadico si è dissolto ed è stato sostituito dall’intrico della foresta e dalle urla dei falconi, voraci metafore dei cacciatori che hanno avvistato la preda.
Gian Domenico fugge un mondo al quale non sente più di appartenere, esce definitivamente dai dipinti, rifiuta di essere statico protagonista di un mondo fittizio e sceglie l’estremo opposto ritagliandosi un regno tutto suo dove la realtà si manifesta in tutta la sua crudezza e dove può essere finalmente re di ciò che può dominare: se stesso.
Ecco allora che il testo si compone di due parti distinte: da un periodo culturalmente fervido, di speranza e di riuscita personale, alla perdita dei valori, alla disillusione della realtà. Dalla Tivoli barberiniana alla Mantova dei Gonzaga. Il passaggio brusco tra periodi storici e il modo diverso di affrontare il mondo da parte di Gian Domenico sono sottolineati da un linguaggio pittorico che varia a seconda dello stato d’animo del protagonista: Michon, nella prima parte, evidenzia sapientemente vocaboli che danno l’idea della luce, del chiarore del sole ombreggiato dalla radura, del fresco dell’acqua delle fontane, un linguaggio che evoca il tratteggiare dei pittori di paesaggio in contrapposizione all’uso di termini che, descrivendo un’ambientazione cupa, nebbiosa, sottolineando il freddo e la pioggia, mettono in risalto la scarsità di luce che determina la disfatta ed il tracollo della Mantova dei Gonzaga. Luce e ombra, dunque, percorrono tutto lo spazio narrativo. Michon traduce verbalmente la luminosità vivace, talvolta eccessiva dei cieli dipinti da Claude Lorrain attribuendovi, però una valenza negativa. Infatti nel racconto la luce inonda ogni meta desiderata dal protagonista, rappresenta una sorta di pericolosa attrattiva irrinunciabile che abbaglia Gian Domenico e ne ottunde i sensi. L’ombra, invece, acuisce la sua percettività: il fitto della boscaglia, gli alberi dominatori assoluti della foresta, la nebbia, elementi presenti in ogni dipinto, schermano la luce e restituiscono la possibilità di vedere la realtà spogliata dal bagliore delle illusioni e delle false promesse.
Per concludere, in Michon la pittura assume un ruolo fondamentale, è per lui duplicazione del mondo e dialogo infinito con il visibile. Per rendere la scrittura” visibile” sceglie la forma breve, come ulteriore apparentamento con la pittura, perché l’uso di uno stile veloce, rapido gli dà il ritmo di un’azione che si svolge e si conclude mentre sta ancora scrivendo e gli offre la possibilità di mantenere intatto l’apporto emotivo fornendo, quindi, un messaggio immediato che viene percepito dal lettore sotto forma di immagine: “La peinture et la forme brève ne saisissent que l’insant de la jouissance. Comment ne pas envier la peinture, elle qui dans le mème instant et la mème main tien son incipit et sa chute?” (“La pittura e la forma breve percepiscono solo l’attimo della gioia. Come è possibile non invidiare la pittura, l’unica forma espressiva che comprende nello stesso momento il suo incipit e la sua conclusione?”).
GIANDOMENICO DESIDERI - LE OPERE
di Elena Fumagalli
A partire dal 1633 e per venticinque anni Giandomenico Desideri fu l'unico assistente di Claude Lorrain e visse ininterrottamente nella casa romana del maestro. Così ne parla Filippo Baldinucci nelle sue “Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua” (Firenze, 1681-1728, ed a cura di F. Ranalli, Firenze, 1845-1847, V, 1847, p. 97): "Aveva egli (n.d.r. Claude Lorrain) fin né tempi che gli toccò operare per Urbano Ottavo preso in casa sua, quasi in qualità di servitore, ma particolarmente per macinare i colori, nettare i penneli ed altre cose fare che abbisognavano ad un comodo esercitamento dell'arte sua, un certo giovane d'assai umile condizione, chiamato Gio. Domenico Romano. A questo (…) avevagli con grande amore insegnato a dipingere; quando s'incominciò a vociferar per Roma, che Claudio faceva i quadri a lui: cosa, che di bocca in bocca passando, si condusse finalmente all'orecchio del giovane, il quale tanto se ne invanì, che, dopo di essere stato con lui venticinque anni, (….) si partì di sua casa: e già meditava di farlo chiamare in giudizio, per farsi pagare il salario di tutto il tempo, che egli era stato appresso di lui con trattamenti più da figliuolo, che da sevitore o discepolo. Avuto di ciò contezza il buono artefice, lo volle avere a sé: e condottolo al banco di Santo Spirito, dove ci teneva gran danaro, fecegli contare tanta somma appunto, quanto importava la sua pretensione. Ma non passò poi gran tempo, che Gio. Domenico finì di vivere (…)".
Probabilmente le sue opere andarono quasi subito sotto il nome del maestro, e a tutt'oggi un suo catalogo è difficilmente ricostruibile.
Marcel Roethlisberger, noto studioso di Lorrain, gli attribuisce due opere, tra cui un Paesaggio con ponte (collezione privata) che reca la firma "GDF 1651" (M. Roethlisberger, Claude Lorrain: temi e varianti, in "Paragone", terza serie, 32, luglio 2000, pp. 32-39. tavola 44 b/n).
Io ho proposto di attribuirgli due piccoli ovali della Galleria Palatina di Firenze (Paesaggio con pescatori e Paesaggio con pescatori che tirano a riva le reti), documentati al 1658. Cfr. (E. Fumagalli, Collezionismo mediceo da Cosimo II a Cosimo III: lo stato degli studi e le ricerche in corso, in Geografia del collezionismo. Italia e Francia tra XVI e il XVIII secolo, atti delle giornate di studio dedicate a Giuliano Briganti (Roma, 19-21 settembre 1996) a cura di Oliver Bonfait, Michel Hochmann, Luigi Spezzaferro e Bruno Toscano, Roma, 2001. p. 246 e tavola IIIa, b b/n ).
Una riproduzione a colori del Paesaggio con pescatori si trova in Marco Chiarini, Gallerie e Musei statali di Firenze. I dipinti olandesi del Seicento e del Settecento, Roma Istituto Polografico e Zecca dello Stato, 1989, p.543 (qui attribuito a Hermann van Swanevelt).

|