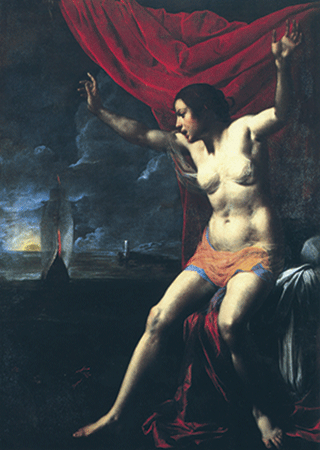|
Anno 11 - N. 31/ 2012
LA PITTURA FIORENTINA DEL SEICENTO
UN NUOVO STILE
È nella traduzione di soggetti tratti dai poemi cavallereschi che la pittura fiorentina del Seicento offre alcuni dei suoi esempi più superbi.
di Elena Fumagalli
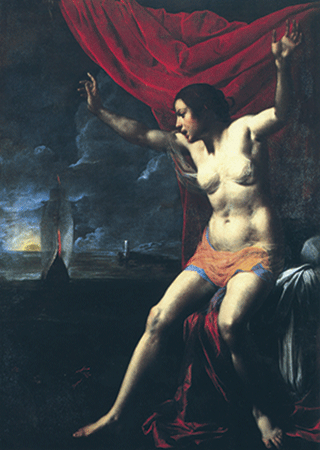
Olimpia abbandonata da Bireno
Giovanni Martinelli
(Montevarchi 1600 - Firenze 1659)
Collezione privata
È indubbio che, rispetto alla fortuna goduta dalla Firenze del Rinascimento nel corso di tutte le epoche successive, quasi a diventare un mito, l’arte del Seicento fiorentino sia passata sotto silenzio fino a date recenti e ancora oggi goda un pieno riconoscimento solo fra gli storici dell’arte e fra alcuni avveduti collezionisti, non da parte del pubblico più largo.
E tuttavia già Luigi Lanzi, allo scadere del Settecento, aveva osservato, nella sua Storia pittorica della Italia, come la riforma della pittura a Firenze iniziata con Ludovico Cigoli (1559-1613) e Gregorio Pagani (1558-1605) avrebbe portato alla nascita di “un nuovo stile, ch’è de’ migliori, pare a me, che in Italia si sian tentati”.
All’interno della tardiva rivalutazione del XVII secolo operata dalla storiografia artistica a partire dall’inizio del Novecento, la sorte del Seicento fiorentino è stata più sfortunata di quella di altre scuole locali italiane, complice il peso da un lato del periodo rinascimentale precedente, dall’altro di una tradizione artistica locale che giocò un ruolo di predominio, limitando e controllando le influenze esterne, che pure ci furono, con numerose presenze in città di artisti stranieri. Rispetto a tendenze caravaggesche, classiciste e poi nettamente barocche che altre scuole pittoriche italiane hanno potuto vantare nel corso del Seicento in una successione cronologica ormai codificata (si pensi in primo luogo a Roma e Napoli), la coeva storia della pittura a Firenze è stata diversa. Essa si è sviluppata, per molti aspetti, attraverso una sostanziale continuità con il tardo Cinquecento, senza le rotture che altrove hanno fatto deviare, anche bruscamente, il corso della tradizione.
Uno degli aspetti più originali della pittura fiorentina del Seicento è stato ormai evidenziato nell’interpretazione dei grandi classici della letteratura moderna – Dante, Boccaccio, Ariosto, Tasso –, tanto discussi dalle accademie della città quanto amati dagli artisti e dai committenti dell’epoca. Una tradizione risalente al De pictura di Leon Battista Alberti (1436) aveva stabilito che la pittura di storia (cioè quella rappresentante la figura umana in azione) occupava il primo posto nella gerarchia dei generi artistici e questa norma fu sempre molto sentita a Firenze, tanto che generi minori quali il paesaggio, la natura morta, la battaglia, la scena di vita quotidiana ebbero scarsa fortuna rispetto ad altri centri. All’interno della categoria della pittura di storia, il Seicento a Firenze contò una straordinaria fortuna visiva dei poemi cavallereschi del secolo precedente (l’Orlando Furioso dell’Ariosto e la Gerusalemme Liberata del Tasso), senza dimenticare le opere più antiche dei grandi letterati toscani, quali la Divina Commedia di Dante e il Decameron di Boccaccio.
Altro aspetto peculiare della pittura fiorentina del Seicento fu il rapporto con il mondo della musica e del teatro, il famoso “recitar cantando” della Camerata de’ Bardi. I membri della Camerata (un gruppo di nobili che si incontrava in modo informale e discuteva di musica, letteratura, arte) credevano di “resuscitare la tragedia greca nella sua supposta unità di musica e di poesia” e al tempo stesso ne ipotizzavano un’eredità presunta appunto nello stile del “recitar cantando”, proposto nella nuova forma melodica del melodramma. Il “recitar cantando” atto a muovere gli “affetti” trovò così il suo corrispettivo visivo nella traduzione pittorica di storie sacre e profane.
Su un altro versante furono i due maggiori poemi epici cinquecenteschi, il Furioso e la Liberata, a insegnare ai pittori come rappresentare le passioni umane, essendo questo l’aspetto attraverso cui la pittura più si avvicinava alla poesia.
Per la pittura fiorentina dei primi decenni del Seicento la critica ha coniato definizioni originali quali pittura “fiorita”, pittura “morbida” o “pittura di costume”, che molto bene si attagliano a quel filone di quadri da stanza raffinati e preziosi che ebbe il suo iniziatore in Ludovico Cardi detto il Cigoli (1559-1613), il quale trattò i soggetti sacri, soprattutto veterotestamentari, con gli stessi toni impiegati per i soggetti profani: basti qui citare due opere esemplari quali il Sogno di Giacobbe, noto in più versioni tra cui ricordiamo quella della Galleria Palatina (1592 ca.) e quella di Nancy, Musée des Beaux-Arts (1593 o 1592?) e la Castità di Giuseppe (Roma, Galleria Borghese, 1610).
Ma è nella traduzione di soggetti tratti dai poemi cavallereschi che la pittura fiorentina del Seicento offre alcuni dei suoi esempi più superbi. Oltre che dall’aspetto “costumbrista” – che si traduce nella riproduzione accattivante di stoffe lavorate, accessori raffinati, gioielli preziosi –, l’occhio dello spettatore è catturato, oggi come allora, dal modo di rappresentare le passioni, tradotte con gesti e toni di una teatralità spesso molto vicina al mondo dello spettacolo, come spesso lo è anche l’abbigliamento dei personaggi: d’altra parte la frequentazione e la pratica del mondo della musica e del teatro, così come, in alcuni casi, di quello delle accademie letterarie, era parte integrante della vita dei pittori stessi, e di questo bisogna tenere conto. Si veda, ad esempio, l’Olimpia abbandonata da Bireno di Giovanni Martinelli (1600-1659), che con enfasi teatrale leva le braccia al cielo, sentendosi abbandonata, alla vista della nave su cui si sta allontanando l’amato Bireno (Orlando furioso, X, 21).
Spesso questo tipo di soggetti va letto in una chiave morale, che rimanda alla percezione predominante che se ne aveva all’epoca, vale a dire quali modelli di un codice di comportamento. Si consideri l’episodio di Angelica che si cela a Ruggiero, più volte rappresentato da Giovanni Bilivert (1585-1644), allievo del Cigoli. Esso è tratto dall’ultima ottava del canto X e dalle prime dell’XI dell’Orlando Furioso dell’Ariosto: dopo aver portato in salvo dal mostro marino Angelica, che si trovava nuda legata a una roccia, Ruggiero non riesce a trattenere il proprio desiderio verso la fanciulla e inizia così a spogliarsi dell’armatura. “Gittato avea Ruggier l’asta e lo scudo, / e si traea l’altre arme impaziente; / quando abbassando pel bel corpo ignudo / la donna gli occhi vergognosamente, / si vide in dito il prezioso annello” (XI, 3), affidatole dallo stesso Ruggiero. “Or che sel vede, come ho detto, in mano, / sì di stupor e d’allegrezza è piena, / che quasi dubbia di sognarsi invano, / agli occhi, alla man sua dà fede a pena. / Del dito se lo leva, e a mano a mano / sel chiude in bocca: e in men che non balena, / così dagli occhi di Ruggier si cela, / come fa il sol quando la nube il vela” (XI, 6). Bilivert ha seguito alla lettera il testo del poema, che sottolinea esplicitamente la nudità di Angelica, scegliendo di porre in risalto la figura femminile rappresentata di profilo contro uno sfondo paesaggistico volutamente scuro, mentre porta alla bocca l’anello magico che la farà scomparire agli occhi di Ruggiero, avvitato su se stesso nell’atto di togliersi le armi (già in parte a terra ai suoi piedi, “natura in posa” sullo sfondo del mare in burrasca). Sullo sfondo, il mare e la roccia che si trova accanto alla mano destra del cavaliere ricordano l’avvenuta liberazione di Angelica dal mostro, come pure l’ippogrifo, dalla parte opposta, che si allontana in cielo. Tutti i commenti cinquecenteschi di questo episodio sottolineano la perdita della ragione da parte del protagonista, accecato dalla bassezza del desiderio carnale: il soggetto è dunque da considerare un monito a non cedere alla passione.
Altro aspetto già da tempo messo a fuoco come caratteristico dell’arte del Seicento fiorentino è quello di una vena “giocosa e caricata”, in parallelo, anche in questo caso, con una produzione letteraria che, nata col toscano Francesco Berni (1497-1535), ebbe fortuna fino al Settecento inoltrato. Questo aspetto giocoso, talvolta legato anche al mondo della commedia dell’arte, risulta ben rappresentato soprattutto dalla produzione grafica di alcuni artisti attivi a Firenze, primo fra tutti il lorenese Jacques Callot (1592-1635), al servizio dei Medici dal 1611 al 1621.
Esemplificativi del gusto fiorentino del Seicento sono anche due tipologie di opere, particolari l’una per il supporto, l’altra per il formato: i dipinti su pietra e le mezze figure allegoriche. La pittura su pietra godette particolare fortuna a Firenze (soprattutto nei primi decenni del Seicento), alimentata dal fatto che, rispetto alle pietre dure e alla lavagna, la “pietra d’Arno” o “paesina” offriva una svariata gamma di forme cui accordare una raffigurazione. Riguardo alle “mezze figure” allegoriche, siamo di fronte a una produzione assai diffusa, la cui fortuna nella storia del collezionismo di dipinti a Firenze appare più tarda rispetto a quella dei temi letterari.
È a partire dagli anni Trenta e poi soprattutto negli anni Quaranta che si registra un vero e proprio exploit di questi soggetti, a cui nessuno dei pittori fiorentini fu estraneo: un fenomeno che deve essere approfondito anche in relazione alla committenza e ai circoli accademici e culturali dell’epoca.

|