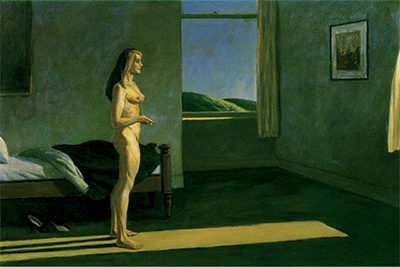|
Anno 9 - N. 26/ 2010
EDWARD HOPPER
Il fascino discreto della sobrietà
La sua pittura sembra una trasposizione visiva
della beat generation di Jack Kerouac [...]
“Nei quadri di Hopper ad accadere
sono le cose che hanno a che fare con l’attesa”
Mark Strand
di Gabriella Colletti
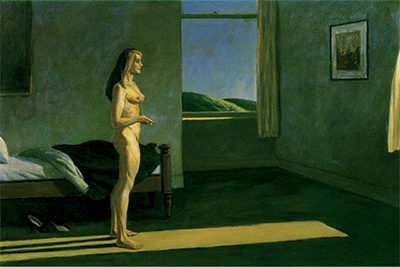
A Woman in the Sun (1961)
Questo lavoro nasce sul ricordo della recente retrospettiva – la prima grande mostra di Edward Hopper in Italia – del caposcuola del Realismo americano, tenutasi a Milano (Palazzo Reale) lo scorso inverno.
Edward Hopper nasce il 22 luglio del 1882, a Nyack, una cittadina sull’Hudson a quaranta chilometri da New York. Da ragazzo sua grande passione furono le barche, ne progettò e costruì una, ma non andò molto lontano. Trascorreva interi pomeriggi al porto di Nyack o lungo la riva del fiume, dove si riunivano i pittori dell’Hudson River School. A contatto con una natura vasta e luminosa ben presto si manifestò in Edward l’inclinazione al disegno, che la famiglia non ostacolò, indirizzando il giovane verso un tipo di scuola d’arte commerciale. A New York studiò alla Chase School disegno e illustrazione. Diplomatosi nel 1906, iniziò a lavorare per riviste e giornali come illustratore pubblicitario, lavoro che detestava e lasciò definitivamente nel 1924.
Grazie ai proventi dei primi lavori poté recarsi a Parigi. Partì nell’autunno del 1906 e si fermò fino all’agosto dell’anno successivo. Con Les demoiselles d’Avignon di Picasso, il 1907 sancisce la nascita del Cubismo; tuttavia il giovane americano non sembra interessato alle novità delle Avanguardie Artistiche e non frequenta la cerchia di artisti che si riunisce attorno a Gertrude Stein. Non può condividere con il Cubismo l’aspetto autoreferenziale; quanto all’Astrattismo, che nascerà pochi anni dopo, è troppo avulso dalla vita e lontano dalla sua ricerca il cui centro sarà sempre il referente, vale a dire l’oggetto immerso nella luce e da essa rivelato. Come ogni rivoluzionario del Realismo è la luce ad interessarlo. Questa illuminazione avviene a Parigi. Scrive nell’Autobiografia: “La luce era diversa da qualunque cosa avessi mai visto prima. Le ombre erano luminose: c’era più luce riflessa. Perfino sotto i ponti c’era una certa luminosità. Forse perché le nuvole sono più basse, proprio sopra il tetto delle case”. La luce rivela l’architettura delle forme, i rapporti stereometrici tra i corpi e lo spazio in cui sono situati. La tavolozza di Hopper si schiarisce, l’azzurro dei cieli pare verniciato come dopo un acquazzone primaverile. I toni cupi della pittura d’esordio spariscono, le tinte esprimono freschezza, trasparenza, leggerezza. Il giovane Hopper è contagiato dalla gioia di vivere parigina, ammaliato dalle feste che animano i boulevard e le rive della Senna. Una folla di studenti e artisti si diverte in ogni ora del giorno e della notte. Ma è soprattutto al crepuscolo, quando le ombre azzurrine della sera danzano e le luci artificiali sfavillano specchiandosi nella Senna, che l’atmosfera diviene magica. È lo stesso fascino che emana Soir bleu, un olio del 1914, nato sul ricordo dell’esperienza parigina, esposto al MacDowell Club a un anno di distanza e subito stroncato dalla critica. Da quel momento non esporrà più Soir bleu per lungo tempo, almeno fino a quando non otterrà la fama e il successo. I colori si schiariscono ancor più, fino a divenire trasparenti, durante il secondo soggiorno parigino. Come in Le bistrot o The Wine (La bottega del vino), 1909. Una luce primaverile, pulsante, viva cade sulle figure degli avventori in primo piano seduti a un tavolino e si espande abbracciando il paesaggio. Gioca con il riverbero dell’acqua sul fiume e in lontananza con i cipressi, incurvati dal vento. La stessa luce mobile si ritrova in Le Pont des Arts e Le Parc de Saint Cloud.
In realtà, fin da subito si interessò alla luce. Dai suoi primi studi. Nonostante siano rivestiti di una patina scura e prevalgano atmosfere in penombra o notturni. Diretta antitesi dell’oscuro è il chiaro. E per ricostruire l’unità originaria che è pienezza e felicità entrambi i momenti sono necessari. È innegabile: a Hopper interessa l’unità. Felice coincidenza del destino è il viaggio a Parigi che permette al giovane pittore di ammirare dal vivo gli impressionisti, i fiamminghi, gli olandesi, Vermeer di Delft soprattutto, Rembrandt, Frans Hals. Oltre allo studio delle opere dei maestri è l’esigenza di uscire en plein air a dipingere la luce e i paesaggi di quella straordinaria città di cui si innamorò, anche se si tratta di schizzi rielaborati in un secondo tempo nel chiuso del suo atelier - Hopper preferì sempre dipingere all’interno del suo studio -.
Al ritorno dall’Europa tutto gli apparve grossolano, ben lontano dalla “gioiosa effervescenza parigina”.
Nessun messaggio di critica sociale è contenuto nella sua poetica. C’è dell’altro. Le figure dei suoi quadri appaiono isolate, spesso si tratta di una figura sola, come in Automat (Tavola calda), 1927; letto dalla critica come emblema della solitudine umana. Una giovane donna sorseggia un caffè in un Automat - locale privo di personale di servizio in cui gli avventori si servono da soli presso distributori automatici -. Lo sguardo è chino sulla tazza di caffè, l’espressione assorta, impenetrabili i pensieri, ma l’espressione è malinconica.
La sua pittura sembra una trasposizione visiva della beat generation di Jack Kerouac. Figure dell’attesa e della nostalgia, i personaggi dei suoi quadri. Come la bella ragazza in Summertime, 1943, e la giovane sulla soglia di South Carolina Morning (1955), che punta lo sguardo verso lo spettatore e sembra interrogarlo sul ritardo di colui che sta aspettando. Nello stesso tempo anelano ad una relazione autentica, a stabilire un contatto. Sia in Summertime che in South Carolina Morning, la figura è ripiegata su se stessa, sul proprio passato, come in Automat. Non vi è alcuna possibilità di dialogo, ma nostalgia. Più delle altre figure, la giovane di Summertime è creatura che si volge alla luce come un girasole. È la luce quel quid che mette in relazione qualcuno con una presenza. Ma qui si tratta di una presenza assenza. Invano i personaggi cercano la presenza dell’altro. Novella Clizia guarda lontano nella luce, aspettando che il raggio luminoso le riveli chi sta aspettando. Figure dello spaesamento e dell’angoscia suscitate dalle grandi metropoli. Come nell’icona della sua pittura Nighthawks (Nottambuli), 1942. O in Gas, 1940. In una stazione di benzina, un uomo compie gesti meccanici a un distributore, sullo sfondo la natura avvolta nelle prime ombre della sera. Si ode un silenzio insopportabile, gravido di attesa. Un silenzio ammantato di mistero aleggia in Night Shadow, un’acquaforte del 1921. Atmosfere sospese e allucinate in Second Story Sunlight, 1960, in Cape Code Morning, 1950, in A Woman in the Sun, 1961, in Morning Sun, 1952. Si prova un senso di abbandono davanti a certi luoghi. Impossibile non pensare a House by The Railroad (Casa vicino alla ferrovia), 1925 – uno dei quadri più famosi di Hopper - dalle cupe e austere linee vittoriane che Hitchock volle per la dimora dell’assassino Norman Bates nel film Psyco (1960).
Scrive Hopper nell’Autobiografia: “Il mio ideale in pittura è sempre stato la trascrizione più esatta possibile delle impressioni più intime che mi suscita la natura. Se questo è un fine irraggiungibile, allora lo è anche la perfezione, e questo vale per ogni ideale pittorico e ogni attività dell’uomo”.
L’uomo primitivo inventò le arti figurative a partire dall’ornamento. Ecco dispiegarsi una filigrana floreale, un racemo si fa arabesco, la linea serpentinata che accarezza sinuosa lo spazio diviene infinita. Inesauribile. Inesauribile pulsione a dominare ogni particella di spazio disponibile con figure antropomorfe o geometriche. Questo avvenne per un inesauribile desiderio di comunicare ed esprimere, senza dubbio, ma soprattutto il movente è da ricercare nella paura. Per sconfiggere l’horror vacui, il terrore dei grandi spazi aperti - deserti infuocati, vaste praterie, desolate distese di ghiacci, in cui lo sguardo si perde e l’uomo si smarrisce -. L’uomo, abitante dello spazio aperto, fu artefice e architetto, ma anche consumatore e defraudatore della sua dimora, il mondo. Hopper esasperò la paura che nasce dal sentimento dello spazio aperto con le gite in macchina, “quell’avanzare che vede levarsi davanti a sé, e poi scomparire per sempre nel retrovisore, luoghi dall’evidenza precaria”.
Così scrive il grande poeta Yves Bonnefoy, in Edward Hopper La fotosintesi dell’essere (Abscondita, Milano 2009, p. 18). Dipinge la precarietà del vivere, connotata dai luoghi privi di identità, a lui tanto cari o, forse, semplicemente, di cui non può fare a meno, in quanto presenze abituali della sua esperienza quotidiana. Soggetti dei suoi quadri sono treni, stanze d’albergo, motel, sale cinematografiche, stazioni di servizio, interni di appartamenti, locali notturni, teatri. Luoghi della transitorietà, in cui si staziona per un certo periodo dell’esistenza. Luoghi che hanno la peculiarità di somigliare a sale d’attesa e di somigliarsi fra loro. Luoghi anonimi. Ma all’improvviso irrompe la luce a mostrare qualcosa di inaspettato. Allora è possibile l’autenticità.
Nella chiacchiera non c’è comprensione autentica, bensì indifferenza, interscambiabilità dei ruoli. Nella dimensione della chiacchiera nessuno è se stesso in modo autentico. Tutte le figure esibite da Hopper cercano l’autenticità sopra ogni altra cosa. Non possono che essere silenziose. Spalancano la finestra per abbeverarsi alla sorgente luminosa. Hanno sete di luce. Colte nell’attimo in cui sono preda di un turbamento, un trasalimento, un sussulto dell’anima. È forse il mondo come tale a rivelarsi loro? “Nel davanti-a-che-dell’angoscia si rivela il nulla come tale” (M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi & C, Milano 1992, p. 234). Nell’angoscia il mondo appare insignificante. L’esserci non si sente più a casa propria. Per afferrare la propria autenticità occorre fare silenzio.
Lo “spogliamento” dello spazio, della figura e in generale dell’oggetto rappresentato in modo il più neutrale possibile, permette allo spettatore di riempire i vuoti intenzionalmente lasciati dal pittore con i propri vissuti. E crea, inoltre, mistero, suspence. Scrive Bonnefoy: “Hopper elimina dai disegni preparatori tutto ciò che potrebbe riportarlo alla persona che posa, e la riduce a caratteristiche del tutto generali” (in Ibid., p. 34). Non intende certo fare dei ritratti, né tantomeno idealizzare i personaggi, specie quelli femminili. Tanto belli quanto può esserlo una natura morta. E non lo sono nei canoni tradizionali la donna nuda in piedi di A Woman in The Sun (Una donna al sole), 1961, e la donna seduta sul letto che guarda la finestra spalancata da cui entrano la luce e l’aria del mattino in Morning Sun (Sole del mattino), capolavoro del 1952.
Nella dimensione anonima, impersonale, neutra irrompe la luce a far dileguare la medietà quotidiana del si-stesso inautentico. Quel trasalimento interiore è la possibilità del soggetto di scoprire la propria natura autentica.
Hopper riduce al grado zero l’ornamento. Sceglie il disadorno, veicolo che conduce all’essenziale. La sua è pittura della sobrietà elevata a sistema. Molto deve in questa sua ricerca a Vermeer. Di lui scrisse l’amico e allora pittore affermato Charles Burchfield in un articolo su “Art News” del 1950: “Sembra che ci sia qualcosa di ineluttabilmente coerente in tutto ciò che riguarda Hopper e il suo lavoro: anche il suo aspetto fisico, la modestia quasi imbarazzante con cui considera la sua arte, i suoi modi dimessi. Onestà è la parola che viene subito in mente guardando l’uomo e la sua arte”.
L’oggetto in primo piano è immerso in un bagno di luce, e tuttavia rimane nella composizione una zona d’ombra, impossibile da eludere. È lì in quanto presenza inquietante e ci osserva. Si tratta del bosco nello sfondo. Per Strand (in Mark Strand, Edward Hopper Un poeta legge un pittore, Donzelli, Roma 2003) ) “la presenza della natura è oscura, intricata, impenetrabile”. Ed è giusto che lo sia, ai fini del raggiungimento dell’armonia, dell’unità. Il caos primigenio è contrapposto all’ordine. Negli interni di Hopper, lindi e minimalisti, dai mobili privi di soprammobili, vi è una finestra, oggetto che mette in relazione l’interno con l’esterno e viceversa. Oppure una scala che conduce al piano superiore. Dalla finestra o dalla porta scorgiamo una massa scura indistinta. È la natura al di fuori dello spazio abitativo. Luogo misterioso e forse anche minaccioso, comunque da tenere lontano. Metafora dell’inconscio, non-luogo in cui agiscono forze oscure, pulsioni, istinti. Una natura selvaggia è nello sfondo di Alba in Pennsylvania, 1948, e nello stesso Gas, oltre che in tanti altri quadri. Ma decisamente più inquietante di tutti è Stairway, (Scala), 1949. Dove conduce la scala? Perché la porta è spalancata? Domande, queste, in fondo superflue. Impossibile trovare una risposta adeguata.
La pienezza della luce era stata raggiunta già all’inizio in Squam Light, 1912. Era forse la rappresentazione della felicità? Ma qui non vi è alcuna figura umana. La natura “sale” e segue l’andatura serpeggiante del sentiero che ci conduce in alto, alla meta della composizione: il faro in piena luce, splendente di bianco. La sommità della lanterna dai mattoni rossi è in ombra. Squam Light esprime la pienezza d’essere, la felicità dell’istante. In fondo a Hopper ciò che importava era “dipingere la luce sull’angolo di un muro, su un tetto”.
DIDASCALIE IMMAGINI
Autoritratto (1906) - Edward Hopper - (Nyack, 1882 - New York, 1967)
Nighthawks (1942)
Le bistrot o The Wine (1909)
Squam Light (1912)
Soir bleu (1914)
House by The Railroad (1925)
Automat (1927)
Gas (1940)
Summertime (1943)
Morning Sun (1952)
South Carolina Morning (1955)
A Woman in the Sun (1961)

|