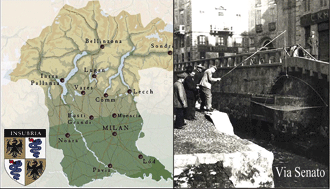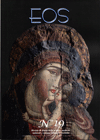|
Anno 7 - N. 21/ 2008
"NO FUTURE/MINGA DE FUTUR"
Il dubbio avvenire della lingua insubre
L'evoluzione linguistica è incessante. Nel caso del milanese, si deve però parlare più esattamente di una decadenza.
Siamo un po' a corto di parole quando dobbiamo parlare del milanese. vogliamo chiamarlo dialetto? la parola designa una variante, di solito su base geografica, di una lingua. cioè prima viene la lingua, poi il dialetto che la modifica o, secondo alcuni, perfino la corrompe. Ma [...]
di Paolo Brera
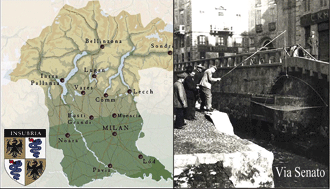
Sembra appropriato iniziare un discorso sul milanese con un sonetto composto dal più grande poeta che l’abbia usato per scrivere, Carlo Porta. Avviso subito che anche una persona che sia nata e vissuta a Milano negli ultimi trent’anni di regola non riesce a decifrarlo bene, questo sonetto, perciò ne darò, in fondo a questo intervento, una traduzione in italiano:
Quand vedessev on pubblegh funzionari…
Quand vedessev on pubblegh funzionari
A scialalla coj fiocch senza vergogna,
disii pur che l’è segn ch’oltra el salari
el spend luu del fatt sò quell che besogna.
Quand savessev del franch che all’incontrari
No ‘l gh’ha del sò che i ball ch’el ne bologna,
allora senza nanch vess temerari
disii ch’el gratta, senza avegh la rogna.
Quand intrattant ch’el gratta allegrament
vedessev che i soeu capp riden e tasen,
disii pur che l’è segn che san nient.
Ma quand poeù ve sentissev quaj ribrezz
perchè a dì che san nient l’è on dagh dell’asen,
giustamela e disii che fan a mezz.
Appurato dunque che il milanese si presta alla produzione di cultura quanto altre parlate locali del nostro Paese, al momento di parlare di esso si presenta un problema.
Siamo un po’ a corto di parole quando dobbiamo parlare del milanese. Vogliamo chiamarlo dialetto? La parola designa una variante, di solito su base geografica, di una lingua. Cioè prima viene la lingua, poi il dialetto che la modifica o, secondo alcuni, perfino la corrompe. Ma il milanese non è una corruzione o una modificazione dell’italiano, anche se molti di coloro stessi che lo parlano lo considerano qualcosa di simile, una variante locale della lingua. A tal punto che si può prendere una parola italiana, imporle certe modifiche sistematiche, e venirsene fuori con qualcosa che sembra una parola milanese. Lo sembra, ma non lo è, anche se può sempre diventarlo grazie a un processo di osmosi linguistica alimentato dal diffuso bilinguismo. Appunto un tale processo si è andato verificando fin qui per almeno un paio di secoli e ha portato alla nascita di numerose parole nuove, che hanno sostituito quelle locali originarie. Più avanti farò qualche esempio.
Potremmo considerare dialetto il milanese, al pari del comasco o del luganese, se la lingua di riferimento fosse l’insubre o lombardo occidentale. L’insubre è l’idioma locale più compreso in Italia e forse il più parlato – visto che l’area urbana di Milano arriva da sola a quasi sette milioni di abitanti, cui si devono aggiungere la Svizzera Italiana, buona parte del Novarese e del Lodigiano, la Valtellina e la val Chiavenna, cioè le aree che formavano la vecchia Insubria preromana. Mentre è relativamente facile parlare di dialetto per altre parlate locali – è plausibile considerare una frase irta di Z pronunciate come in italiano, per esempio “Ul gh’ha suu di colzón da pocch prézz”, quale uno può sentire sulle sponde del lago di Pusiano, come una variante del più rotondo “El gh’ha suu di calzón de pocch prezz” che si potrebbe invece sentire a Milano, con l’italianismo colto di quel pocch prezz invece di de spend pocch – la frase milanese dopotutto è fondante per la parlata insubre, perché alla base di questa c’è l’uso della metropoli.
Resta che purtroppo nemmeno l’insubre si può davvero considerare una lingua alla stessa stregua dell’italiano o del polacco. Ci sono troppe cose che non si possono esprimere in insubre. Provate a parlare di filosofia o di teologia! mancano letteralmente le parole. Siamo di fronte al problema che in italiano abbiamo con certi concetti nuovi, legati per esempio al mondo dei computer, che hanno un nome in inglese ma non sempre in italiano. In italiano abbiamo preso vocaboli come “software” e “computer” e adattato altri come “scansire”. In milanese si fa la stessa cosa con le parole italiane, ma non solo in certi àmbiti specialistici. Perfino uno dei poeti milanesi più affermati e significativi di oggi attinge a tal punto il suo vocabolario dall’italiano da usare in una poesia l’espressione i preghier, con articolo e terminazione plurale milanese di una parola italiana, anziché i orazión che sarebbe il vero termine Lamberside. L’uso della metropoli si diffonde poi gradualmente al resto della zona insubre, con la complicazione aggiuntiva dell’influsso tedesco nel Ticino e nei Grigioni (dove per dire inflazione si dice ul rincar e quando i negozi fanno un campagna di sconti si dice che c’è ona azzión, dal tedesco Aktion). Possiamo fare altri esempi di prestito lessicale dall’italiano: scoeura, divenuto scòla, “scuola”, candoeura, oggi candela, voeulta, ormai vòlta, sgorà, sostituito da volà, “volare”.
L’evoluzione linguistica è incessante. Nel caso del milanese, si deve però parlare più esattamente di una decadenza. La parlata originaria della nostra zona si va puramente e semplicemente sciogliendo in un’altra, che è l’italiano regionale (l’italiano come lo si parla in Lombardia, un sottoinsieme particolare dell’italiano). È abbastanza difficile descrivere le modalità di questo processo e non è ben chiaro quali concetti siano appropriati in una situazione oggi così fluida. Io ho cercato fin qui di contrastare una visione del milanese come deformazione dell’italiano, che sarebbe un togliergli dignità; ma non intendo certo negare che l’italiano e il milanese siano due realtà ben diverse, e che chiamare entrambe “lingue” allo stesso titolo sembri un po’ sforzato.
Dopo l’unità d’Italia, l’italiano conosciuto da una parte minima della popolazione – lingua puramente scritta e non parlata, come osservò Ugo Foscolo – cominciò a cambiare sotto l’aspetto sociologico. Negli ultimi decenni dell’Ottocento si formarono due grandi laboratori linguistici, Roma e Milano, nei quali per motivi diversi (burocrazia statale del regio governo e costruzioni nella prima città, industria e finanza nell’altra) si concentrava popolazione immigrata proveniente da tutte le regioni d’Italia. La popolarizzazione operata da Alessandro Manzoni con lo sciacquare i panni in Arno era il presupposto del nuovo passo in avanti della lingua nazionale, quello in cui cominciò ad essere effettivamente parlata e non solo scritta. Sarà il caso di citare il fatto che Manzoni stesso, nel suo breve passaggio al parlamento del Regno d’Italia, chiedeva immancabilmente a un altro deputato proveniente dalla Toscana di aiutarlo a scrivere i suoi interventi in aula, visto che lui con l’italiano non se la cavava troppo bene. Meglio gli andava con il francese e ovviamente il milanese. Eppure l’unica cosa che in vita sua scrisse in milanese furono i seguenti quattro versi, rivolti a Carlo Porta che per una pasquinata si era finto un’altra persona:
On badee ch’el voeur fà de sapientón
el se toeu subet via per on badee;
ma on omm de coo ch’el voeur parè minción
el se mett anca luu in d'on bell cuntee.
La traduzione è: «Uno scemo che vuole atteggiarsi a sapientone / si fa subito pescare per quello che è; / ma un uomo dalla testa fina che vuole sembrare un minchione / si mette anche lui in un bel pasticcio». Firmato Don Lissander Manzón. Ho aggiornato l’ortografia.
Ma la gestazione dell’italiano parlato fu molto lenta. Almeno fino agli anni Cinquanta del secolo scorso vi fu una specie di diarchia, in cui l’italiano occupava una parte degli àmbiti della comunicazione e il milanese un’altra, con un continuo ampliamento delle sfere in cui gli scambi espressivi avvenivano in italiano e la speculare riduzione di quelle in cui correva invece il milanese. Questo fenomeno non ha niente di eccezionale: sono numerosi oggi in Italia gli ambienti in cui si parla di fatto inglese.
Il bi- e trilinguismo erano piuttosto frequenti. L’immigrato della provincia di Pavia che tornava al paese per i lavori agricoli o per le vacanze poteva esprimersi in italiano sul lavoro (o a scuola), in milanese quando andava a fare le compere a Milano e in pavese (che è un idioma abbastanza diverso dall’insubre) nei periodi che trascorreva al paese di origine. Anche chi non aveva addentellati fuori Milano poteva usare una parlata in determinati àmbiti e il milanese in altri. Lo strato superiore della società doveva spesso comunicare anche in occasioni diciamo così “solenni”, e per questo usava l’italiano e il francese (fino agli anni Settanta, in tutta l’Italia era più diffuso dell’inglese). Una parte intermedia, sia autoctona che immigrata, conosceva l’italiano e comunicava di preferenza usando quello, salvo passare al milanese nei rapporti con altri ceti. Al livello più basso stavano l’immigrato che parlava un’altra lingua regionale e l’indigeno che non sapeva esprimersi se non in insubre. Nella prima metà del secolo scorso l’immigrato spesso imparava il milanese, specialmente se veniva da altre aree del Nord Italia. A scuola però si insegnava solo l’italiano, i media erano scritti in italiano, e se uno aveva a che fare con l’amministrazione pubblica, anche questo poteva farlo solo in italiano. Questo insieme di circostanze generava una pressione sociale costante che nei decenni ha spostato i piatti della bilancia dando sempre più peso all’italiano e sempre meno al milanese.
Fino agli anni Quaranta o perfino Cinquanta del secolo scorso, l’aristocrazia e l’alta borghesia si esprimevano senza problemi anche in milanese, e anzi le grandi famiglie erano depositarie di un milanese “nobile”, con un vocabolario molto esteso e particolarità grammaticali che il parlante riusciva a padroneggiare appieno.
Gli anni Cinquanta e Sessanta, con la scolarità di massa, l’immigrazione dal Sud e l’ascesa sociale di ampi strati, segnano una transizione notevole. Lo strato inferiore della società si divide sempre più in una parte che parla di preferenza il milanese e in un’altra, di recente immigrazione, che non lo parla affatto e spesso non ne comprende neppure le frasi più semplici. Questa divisione, precoce nella metropoli, si manifesterà con maggiore lentezza nelle aree meno centrali della parlata insubre, dove anche negli anni Ottanta si registrano casi in cui l’immigrato apprende il dialetto, perlomeno a livello passivo.
Nello stesso periodo, nelle famiglie del ceto medio ci si rivolge ai bambini in italiano: perché il problema sentito è quello che imparino a parlare la lingua nazionale, non il “dialetto”. Quest’ultimo era dato per scontato, ma come risulterà poi, scontato non era. La generazione che oggi ha fra i cinquanta e i sessant’anni cresce dunque comprendendo per lo più il milanese, sia pure senza raffinatezze, ma di regola non lo parla mai, in nessuna occasione. Se posso portare il mio caso personale, le prime parole in milanese le ho pronunciate verso el mezz del camin de la mè vida. Mi riesce più facile sostenere una conversazione in inglese o in francese che in milanese, e ci infilo molti meno italianismi.
E il futuro? Le generazioni successive alla mia non vedono alcun motivo di esprimersi in milanese e non sentono neppure un gran bisogno di capirlo, salvo poche eccezioni. La riabilitazione culturale delle parlate locali ha sì avuto qualche effetto, ma solo Israele, nella storia, è stato in grado di risuscitare una lingua morta, e ho pochi dubbi che il milanese stia tirando gli ultimi, poiché si stanno seccando le radici dell’espressività locale. (Per chi viene da altre regioni d’Italia, specificherò che “tirare gli ultimi” equivale in italiano regionale lombardo a “tirare le cuoia”. Forse dopo tutto un po’ di espressività locale rimane viva!) La situazione dell’insubre nel suo complesso è poco diversa: la strada tracciata sembra essere sostanzialmente la stessa.
Paradossalmente, al momento attuale ci sono più poeti in idioma milanese di quanti ce ne siano mai stati in qualsiasi momento della storia di Milano. Ma non vuol dire: nella città c’è anche più gente che conosce il latino, male, di quanta lo conosceva (e lo parlava) negli anni in cui Milano era la capitale dell’Impero d’Occidente. Latino e milanese colto sono, a titolo diverso ma con risultati in certa misura analoghi, lingue letterarie e non lingue di tutti i giorni. Al muratore egiziano, alla colf filippina o alla commessa nigeriana è impensabile rivolgere la parola in milanese (anche se una residente spagnola, all’indirizzo http://basdalaluna.blogspot.com/, sta dimostrandosi molto disposta a imparare il milanese). Non esistono a Milano milanofoni che non parlano italiano, mentre di italofoni che non parlano e spesso neppure capiscono il milanese, neanche quello più semplice, ce ne sono per così (cioè: molti, in italiano regionale lombardo). La situazione cambia di poco nelle zone della Grande Milano, nel Ticino e nelle provincie di Como, Lecco e Sondrio. Tutto ciò vuol dire che sulla nostra parlata sta scendendo la sera. Ben presto nessuno userà più il milanese nella vita quotidiana.
Questo non toglie nulla né alla letteratura in milanese, che può vantarsi di Bonvesin de la Riva, Carlo Maria Maggi, Carlo Porta, Delio Tessa e molti altri, né alla canzone, che negli ultimi decenni del secolo scorso e oggi ha un Ivan Della Mea e un Enzo Jannacci (né l’uno né l’altro di origine milanese), e tutto sommato neppure al folklore che in certa misura passerà all’espressione italiana. Luciano Salice, proprietario della scuderia Rencati, ha preso a dare ai suoi cavalli nomi che appaiono misteriosi, ma sono chiarissimi a chi mastica un po’ di milanese: Falbrav, Fisich e Sunstrach, cioè Fa el brao, “Fa’ il bravo”, Fisicch, “Fisico”, e Sont stracch, “Sono stanco”. Non toglie nulla, ho detto, ma certo piazza tutto quanto fermamente nel passato, con la stessa dubbia immortalità (anche se con dignità somewhat maggiore) di quel graffito trovato a Pompei nelle vicinanze di un postribolo – il cui autore si immaginava di consegnare all’eternità il fatto che «Hic ego puellas multas futui», e di lui non sappiamo null’altro, neppure se la sua gallissima rivendicazione fosse veritiera.
Quali sono le caratteristiche del milanese?
Nella zona di Milano, il latino arriva nel primo secolo dell’era volgare e si sovrappone al celtico che era parlato in precedenza. Sarà Ottaviano Augusto, irritato dalla statua dedicata a Bruto uccisore di Giulio Cesare che ha trovato nel foro di Milano durante una delle sue prime visite imperiali alla città, a bandire l’uso del celtico nella regione. La colonizzazione latina e l’assimilazione porteranno alla definitiva estinzione della lingua celtica e alla sua parziale reincarnazione nel volgare neolatino di Milano e della Gallia Cisalpina. L’altra influenza forte sulla parlata milanese saranno, nel periodo successivo, le lingue dei popoli germanici che si avvicendarono nell’area: i goti, i longobardi, i franchi; e in epoca moderna, verranno le influenze dello spagnolo, del francese e del tedesco parlato dagli austriaci, peraltro limitate di regola al lessico.
La fonetica è quella dove più evidente è l’impronta celtica.
Il sistema vocalico del milanese comprende i suoni á à é è e ò o u ö i. Il primo è una A molto aperta e tendente un po’ al suono italiano della Ó chiusa; ricorre solo nelle sillabe toniche ed è tipico dei participi passati dei verbi di prima coniugazione (parlaa, cioè “parlato”, si distingue nella pronuncia da parlà, “parlare”). Le vocali à é è ò i sono identiche all’italiano nel suono e nella grafia, come identica è la o che però corrisponde alla U italiana (il suono italiano della O chiusa non esiste in milanese). La u è pronunciata alla francese; la ö, che come la ò si trova solo nelle sillabe toniche, corrisponde al suono eu francese od ö tedesco; mentre e è un suono intermedio fra la E aperta e quella chiusa che ricorre nelle sillabe non accentate.
Queste vocali possono essere lunghe o brevi, e possono anche essere nasalizzate. In milanese, la N e la M semplici non seguite da una vocale non si pronunciano, ma rendono nasale la vocale precedente, pur senza modificarne il timbro come avviene in francese, in portoghese o in polacco. Un franco suono consonantico N o M può essere udito in fine di sillaba, in non molte occasioni, ma viene notato ortograficamente con una doppia: el tramm, i donn, i tosann. La nasalizzazione costituisce un fonema rispetto alla vocale seguita da una consonante nasale pienamente articolata: per esempi, i can sono i cani, ma i cann sono le canne.
Le consonanti sono in larga misura uguali all’italiano, ma il milanese ne ha una in più – la sg che suona come la j francese – e alcune in meno: le due zeta dell’italiano e il suono gli.
La fonetica ha regole abbastanza precise. Una vocale accentata seguita da due consonanti, salvo eccezioni e a meno che la seconda sia una nasale, deve essere pronunciata aperta: una regola che se applicata parlando italiano definisce in larga misura l’accento milanese. Quando nella declinazione, nella coniugazione o nella derivazione l’accento si sposta, la ö e la ò diventano o (la U italiana) mentre la é e la è diventano e (il suono intermedio fra le due). La V ha un suono molto debole e quando segue la o, oppure si trova fra una vocale e una o, scompare del tutto (lavorà, “lavorare”; spesso l’ortografia elimina del tutto la V etimologica: Gioann, “Giovanni”, brao, “bravo”). In fine di parola le consonanti sonore si pronunciano di solito come sorde, mentre in fine di sillaba la D e la T che seguono una N non si pronunciano (se non quando bisogna fare una liaison). Le consonanti doppie si pronunciano come le semplici, ad eccezione delle nasali e di quelle che si trovano in finale di parola, che sono un po’ rafforzate. Quando nella flessione una consonante sonora viene a trovarsi alla fine di una parola, viene per lo più pronunciata come la corrispondente sorda (i nerv, “i nervi”, si pronuncia nerff). Questo tuttavia non avviene sempre: i ròs, “le rose”, si pronuncia rooz. L’ortografia a volte registra il fenomeno, a volte no: el vecc, “il vecchio”, a rigore si dovrebbe scrivere el vegg, dato che il femminile è la veggia; ma si può anche considerare, all’opposto, che vi sia qui una lenizione del suono C intervocalico quando si passa al femminile. Infine, la S semplice scritta fra due vocali ha sempre il suono sonoro: le parole in cui si incontra una S sorda fra due vocali non sono rare, ma occorre notarlo ortograficamente con una consonante doppia (S o Z): la piazza, “la piazza”, i cassett, “le cassette, i cassetti”.
Come si è visto dagli esempi precedenti, il milanese non sente il bisogno di distinguere il femminile dal maschile nell’articolo determinativo plurale, che è i per tutte le parole e quale che sia la loro lettera iniziale: i ass, “gli assi/le assi”, i scarp, “le scarpe”, i omón, “gli omoni”. L’articolo singolare è el per il maschile e la per il femminile; l’uno e l’altro si elidono in l’ davanti a vocale. Le preposizioni articolate sono al, del, sul, (pl. ai, di, sui) mentre nel è un italianismo recente. L’articolo indeterminativo è on, ona e si distingue dal numerale che è vun, vuna (o voeuna). Il plurale è di.
Il plurale dei sostantivi è quasi sempre uguale al singolare, la distinzione essendo affidata al contesto e più in particolare agli articoli. Fanno eccezione i maschili in –ell, che fanno –ei, e i femminili in –a, che al plurale hanno desinenza zero: la tosanna, “la ragazza”, i tosann. Per gli aggettivi sostantivati di provenienza e per diversi altri, a evitare ambiguità, si usa la parola donn, “donne”: i napoletan, “i napoletani (uomini o uomini più donne)”, i donn napoletan, le napoletane.
Rispetto all’italiano, il milanese ha una struttura dei tempi verbali alquanto più semplice: al’indicativo esistono il presente, il passato (prossimo), l’imperfetto, il trapassato prossimo, il futuro e il futuro anteriore: nel verbo vedè, 1ª persona singolare, vèdi, hoo vist, vedevi, avevi vist, vedaroo, avaroo vist; nel condizionale, il presente e il passato: vedaria, avaria vist (poco usato); nel congiuntivo, l’imperfetto e il piuccheperfetto: vedess, avess vist (entrambi in disuso); e poi l’imperativo, il participio passato, il gerundio (in disuso), l’infinito presente e passato. Altri tempi esistevano una volta ma sono ormai del tutto scomparsi.
La negazione in milanese si esprimeva un tempo anche come in spagnolo, con un no premesso alla voce verbale. Oggi quell’uso è tramontato, l’attuale si avvicina a quello popolare francese, con una negazione posposta al verbo che può essere ancora no oppure minga; la frequenza dell’una e dell’altra particella è più o meno la stessa. Minga è il latino mica, “briciola”, con lenizione del suono K intervocalico e poi con un fenomeno fonetico tipico del milanese, la nasalizzazione di molte sillabe accentate aperte. Per “niente, nulla” esistono due espressioni, nagott (o nagotta) e gnent (nient nell’ortografia portiana): la prima, derivando dal latino ani guttam, non può mai stare all’inizio di una frase. Così «Gnent l’è pussee bell che andà a spass» (Niente è più bello che andare a spasso), se decidiamo di usare nagott, diventa «Gh’è nagott de pussee bell…» etc.
Infine, una caratteristica che il milanese ha in comune con il toscano dialettale è la necessità di premettere al verbo un pronome proclitico per la seconda persona singolare e la terza (singolare e plurale), e questo anche quando è già espresso il pronome personale nella sua forma forte. Per la seconda persona singolare si ha addirittura anche un terzo pronome, enclitico, che viene scritto unitamente al verbo e si confonde ormai con una desinenza. Così avremo la coniugazione del verbo parlà, al presente indicativo, nelle seguenti forme: mi parli, ti te parlet, luu el parla, num parlom, vi parlii, lor i parlen.
Non ho altro da aggiungere a questa lapide funeraria della parlata milanese, già prolissa come le Tavole Eugubine. Ecco allora, come ho promesso, e valga da congedo, la traduzione del sonetto di Carlo Porta che ho riportato all’inizio:
Quando vedeste un funzionario pubblico…
Quando vedeste un pubblico funzionario
scialare a tutto spiano senza vergogna,
dite pure che è segno che oltre al salario
lui spende dal suo patrimonio quello che serve.
Quando però sapeste per certo che al contrario
non ha di suo se non le balle che si porta in giro,
allora senza neanche essere temerari
dite che gratta, senza aver la rogna.
Quando intanto che gratta allegramente
vedeste che i suoi capi ridono e tacciono,
dite pure che è segno che non sanno niente.
Ma quando poi sentiste un certo quale ritegno
perché dire che non sanno niente è come dargli degli asini,
mettiamo a posto la cosa e dite che fanno a metà.

|