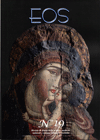|
Anno 7 - N. 19/ 2008
Il caffè delle Muse
AFRICA IN FORME
di Francesco Piscitello

Statua di antenato
(Byo, Congo)
Si osservi la scomposizione cubista delle forme corporee.
Africa in forme è il titolo di una splendida mostra di arte africana alla cui inaugurazione mi ha cortesemente invitato lo scorso 16 maggio l’amico Roberto Masutti, come me appassionato ma assai più di me esperto di questa materia. Nell’ambulacro circolare del romanico Battistero di san Pietro ad Asti - quanto stanno bene insieme la rude espressività del romanico e il vigore africano! - numerose vetrine accolgono maschere e suppellettili sacre, statue di antenati e feticci, oggetti la cui potenza evocativa ha commosso lo stesso Gabriele D’Annunzio, non certo sospetto di partigianeria ai danni dell’arte e della cultura classica, che scrisse: “...e se una statua negra, annerita dai riti e dalle offerte, avesse forza di competere, centauro ferinamente possente in un momento di smarrita visione, con l’ala scattante e sublime della Vittoria di Samotracia?”.
Il grande valore estetico dell’arte africana ha ottenuto solo con moltissimo ritardo il meritato riconoscimento. Fino a tutto l’ottocento le maschere e le sculture di questo continente erano al più oggetto di curiosità etnologica: nessuno attribuiva loro più significato di quello di un ingenuo tentativo, da parte di popolazioni selvagge, di riprodurre la figura umana o animale o di rappresentare chimere mostruose. Ma dopo tutto, osserva ironico André Malraux, “...perché mai i feticci avrebbero dovuto sorprendere i colonizzatori? Essi non dubitavano minimamente del fatto che l’artista deve imitare il modello, e il negro scolpiva dei miseri pupazzetti solo per l’incapacità razziale di competere con le mirabili teste di cera dei parrucchieri...”
È solo con le avanguardie del primo novecento che l’immensa capacità espressiva della produzione plastica africana viene riconosciuta e valorizzata e finalmente il grande patrimonio artistico e culturale del continente nero trova il suo punto di contatto con l’arte occidentale, esercitando su di essa una poderosa influenza: Picasso, Man Ray, Vlaminck, i Fauves, Braque, Epstein, Modigliani, Klee, Max Ernst sono solo alcuni tra i più noti, non gli unici, debitori europei e americani dell’anonimo scultore fang o dogon, yoruba o kurumba che – silenzioso nel suo raccoglimento e consapevole della dignità sacrale del suo lavoro – sulla soglia della sua capanna nelle foreste del Gabon o sulle alture di Bandiagara, tra le sterpaglie della brousse del Burkina Faso o nelle savane degli altipiani camerunesi, intagliava nel legno di eriodendron la maschera dello spirito propiziatore di fecondità dei campi e delle donne o le statue degli antenati progenitori della famiglia e del clan, Lari e Penati di una Roma lontana, oscura e misteriosa.
L’arte africana non si esaurisce, come comunemente si ritiene, in idoli e feticci ma ha visto, nei fastosi regni dell’antichità (Ifé, Benin, Krinjabo, Ashanti, Igbo-Ukwu, Shongai) il fiorire di un’arte di corte, aulica e raffinata, destinata a celebrare la gloria del sovrano e a sottolineare il prestigio di nobili e dignitari: ma essa non riesce a sedurre, me almeno, con l’emozione, la commozione che suscitano un Mbulu-Ngulu, un Bwiti - muti custodi dei reliquiari nei villaggi kota e mahongwè – o un’antilope Tchi-Wara che sovrasta il casco di vimini indossato da un danzatore bambara durante la danza che sollecita un buon raccolto nei campi di sorgo, esempi mirabili di una produzione plastica che risponde alle necessità sociali, antropologiche, spirituali proprie di quella civiltà.
L’arte tradizionale africana ha un significato prevalentemente religioso, per non dire liturgico. Ciò non vuol dire tuttavia che le statue, e soprattutto le maschere, costituiscano, come per l’iconografia religiosa del mondo occidentale, una mera rappresentazione di divinità o di spiriti: l’oggetto scolpito diviene invece non di rado – attraverso il rito, la cerimonia, la danza – una temporanea o perenne dimora di quello spirito, di quella divinità; o, per dir meglio, la sostanza spirituale, divina, che per sua natura è immateriale, acquista una forma esterna visibile, una materiale concretezza che sono quelle della maschera intagliata, della statua scolpita, le quali costituiscono dunque, per dirla con Vigorelli, un’immagine dell’invisibile. È proprio questa necessità di dare visibilità e concretezza all’invisibile, all’immateriale, l’elemento fondante dell’estetica africana. La statua, la maschera, anche se di modeste dimensioni, sono sempre caratterizzate da una solenne, maestosa monumentalità. Il rispetto della simmetria – dal momento che il carattere disarmonico, dissonante dell’asimmetria non è confacente alla dignità del divino – è rigoroso e universale. Il movimento è quasi nascosto, con gli arti né flessi né estesi ma solo lievemente piegati (movimento latente, come lo chiama Segy): la dinamica, lo slancio di un’azione colta nella pienezza del suo svolgersi contrasterebbero con il carattere di ieratica compostezza che deve connotare l’effigie di un’entità soprannaturale. Ed infine, gli occhi. “Occhi senza sguardo”, come sono stati chiamati, perché rivolti in basso oppure lontano, verso l’infinito, e non verso chi guarda: non è possibile infatti un dialogo, fatto anche solo dall’incontrarsi degli sguardi, tra chi è immerso nelle profondità di una meditazione propria di un dio e chi non può elevare il pensiero oltre i limiti modesti della sua fragile umanità.
È opinione diffusa che la cultura del villaggio, il milieu antropologico dell’arte africana, sia ormai quasi del tutto estinta. Non è così. Sia pure nel pieno di un gigantesco processo di transculturazione che vede il danzatore mascherato indossare talora, sotto il mantello di rafia, blue jeans e t-shirt, le cerimonie sacre, gli esorcismi, i sacrifici si svolgono ancora, gli spiriti aleggiano ancora intorno al villaggio, le donne, la terra, gli armenti non sono fecondi se la fecondità non è favorita da un dio e se questo non viene propiziato con canti e offerte, con danze e pratiche di pietà. In molte regioni gli antichi miti e gli antichi riti sopravvivono, in una difesa senza speranza di un’identità destinata a morire. Sopravvivono resistendo agli assalti di una modernità invasiva e intrusiva. Sopravvivono all’indifferenza, al fastidio delle più giovani generazioni che ne provano talora vergogna come per un marchio di arretratezza culturale. Sopravvivono nascondendosi alla curiosità oltraggiosa e volgare del turista – questo sì un selvaggio – instancabile nel puntare la sua cinepresa su tutto ciò che il pieghevole dell’agenzia organizzatrice del suo viaggio “tutto compreso” gli ha raccomandato come assolutamente tipico, come folklore da non perdere. Sopravvivono in condizioni sempre più avverse, sopravvivono con grande fatica. Sopravvivono con dolore.
Sono stanche, le maschere dell’Africa. Ma non hanno ancora cessato di danzare.

|