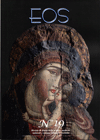|
Anno 7 - N. 19/ 2008
STORIA DELLA MEDICINA
La vita e la persona
LA CURA DEL MALATO TRA BIOETICA E DIRITTO
La medicina contemporanea fornisce ogni giorno grandi
quantità di materiale alla riflessione etica e giuridica.
di Francesco Piscitello

Se l’arte diagnostica ha raggiunto nella nostra epoca livelli altissimi e spesso stupefacenti (EOS, anno 5, n. 13) grazie ad una tecnologia sofisticata, le possibilità di cura sono forse ancora più sconvolgenti.
Ai tradizionali strumenti farmacologici, chirurgici, fisici sempre più evoluti si affiancano oggi metodi e procedure che consentono di entrare nei recessi più profondi della materia vivente, nelle pieghe più intime dei meccanismi della vita stessa: si pensi, ad esempio, al promettente impiego (peraltro in molti casi già in atto) di quelle cellule indifferenziate dette «staminali» che possono essere condotte a differenziarsi in elementi cellulari adulti riportando letteralmente a nuova vita tessuti degenerati.
Soffermarsi anche solo brevemente su ciascuno di questi procedimenti terapeutici richiederebbe uno spazio troppo vasto e, del resto, essi vengono portati sempre più frequentemente a conoscenza di tutti attraverso la stampa, sia pure con qualche imprecisione e talora con enfasi eccessiva. Mi pare tuttavia importante non tralasciarne gli aspetti che maggiormente animano il dibattito culturale e politico: quelli giuridici e quelli etici o, meglio, bioetici.
Il termine «bioetica» è di conio recente e fu usato per la prima volta nel 1971 da V. R. Potter nel titolo e nel testo del saggio Bioethics: Bridge to the Future. Il neologismo ebbe fortuna e già nel 1978, a testimonianza della vitalità di questa disciplina, veniva data alle stampe una Encyclopedia of Bioethics a cura di W. T. Reich nella quale essa viene definita come lo «studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura della salute quando tale condotta viene esaminata alla luce dei valori e dei principi morali». Oggi quella definizione appare notevolmente limitata ed i suoi confini della bioetica si vanno estendendo ma, per gli scopi che si propone questa esposizione, può essere adottata così com’è.
Naturalmente, come fa giustamente notare Engelhardt (1), la varietà delle culture e delle fedi religiose dà luogo a modalità di approccio ai problemi della bioetica che impongono di declinare al plurale questo sostantivo: di questa pluralità tuttavia si possono prendere in considerazione, per brevità, la concezione cattolica, paradigma di una bioetica fondata sulla “sacralità della vita” che appartiene a Dio e della quale l’uomo non ha disponibilità, e quella laica, fondata sulla “qualità della vita”.
Questi principi, tuttavia, non esauriscono l’intera problematica bioetica, ma rappresentano soltanto il criterio guida per assegnare all’imperativo “non uccidere” (o “non ucciderti”) - condiviso peraltro da entrambe le concezioni - una collocazione nella scala delle liceità.
La stessa visione cattolica infatti, non esclude il dare la morte, per esempio, per legittima difesa o per un conflitto militare ed anche per motivi penali: la pena di morte è solo energicamente sconsigliata dalla chiesa cattolica ma non interdetta in via di principio (nella Legge Vaticana del 7 giugno 1929 la pena capitale era prevista in caso di attentato contro la vita, l’integrità o la libertà personale del Pontefice ed abolita dal codice vaticano nel 1967 da Paolo VI mentre è stata rimossa dalla Legge Fondamentale – l’equivalente della nostra Costituzione – da Giovanni Paolo II il 12 febbraio 2001).
L’INIZIO E LA FINE DEL PERCORSO UMANO
La pura e semplice soppressione di un ovulo o di uno spermatozoo - che sono certamente vita, ma non persona - non rappresenta un fatto di interesse bioetico: la questione si pone solo quando l’ovulo venga fecondato. Per la dottrina cattolica questo è già persona mentre lo diventa più tardi secondo una concezione laica (in momenti diversi secondo le varie scuole di pensiero che non possono qui essere esaminate): di qui il diverso atteggiamento nei confronti dell’interruzione volontaria della gravidanza e, nel caso di embrioni plurimi che si ottengono nelle procedure di fecondazione in vitro, del reimpianto degli stessi. Le tematiche dell’interruzione della gravidanza, della fecondazione assistita, delle ricerche diagnostiche prenatali e dei provvedimenti conseguenti, per complesse che possano presentarsi nella pratica, sono tuttavia conseguenza abbastanza automatica dei principi sopra ricordati.
Assai più complessa, anche da punto di vista dottrinale, è la problematica connessa alla conclusione dell’esistenza. Per secoli l’arresto dell’attività respiratoria e di quella circolatoria è stato impiegato come criterio per definire il decesso. Ma davvero la morte coincide con questo? Il crescere della barba, delle unghie, dei capelli – fenomeni sicuramente biologici - ancora per qualche giorno dopo quell’evento è forse una curiosità della natura? O non è invece l’effetto di una scelta umana che ha deciso di collocare l’istante della morte in un momento in cui i fenomeni vitali non sono completamente cessati? E questa scelta non potrebbe cambiare, non si potrebbe collocare il decesso un po’ più in qua o un po’ più in là?
È quello che è stato fatto. Dopo il 1967, anno del primo trapianto cardiaco, si è reso necessario ridefinire lo stato di morte. Quand’anche un cuore destinato al trapianto venisse prelevato al donatore un istante dopo il decesso definito col vecchio criterio – arresto del circolo e del respiro – le operazioni di espianto e di impianto nel ricevente lascerebbero il cuore stesso troppo a lungo privo di ossigeno danneggiandolo irreversibilmente. Da allora moltissimi stati, cominciando dal Kansas che per primo, nel 1970 lo ha accolto nella propria legislazione, adottano come criterio quello della morte cerebrale, ossia della cessazione irreversibile delle attività cerebrali tanto psichiche che di regolazione delle funzioni vegetative (fatta salva quella cardiaca che si può svolgere anche autonomamente dal controllo nervoso) come quella respiratoria, che deve essere assicurata meccanicamente. Il criterio della morte cerebrale – che quando non si pongano in atto procedure sanitarie come la respirazione assistita è rapidamente seguita dalla morte clinica secondo i criteri tradizionali – ha reso praticabile il trapianto di organi senza che questi subiscano il deterioramento legato ad un ritardato espianto. La morte cerebrale viene accertata da un comitato di diversi specialisti secondo modalità definite dalla legge. Essa, se non suscita contrasti tra la concezione bioetica cattolica e quella laica, non è tuttavia universalmente accettata: il Giappone, per esempio, non ne ha accolto il principio nella propria legislazione ed esistono in molti paesi associazioni che la ostacolano come, in Italia, la Lega Nazionale contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente.
LA PERSONA E LA MORTE
La morte totale, completa è, tautologicamente, la conclusione del processo di dissoluzione della materia vivente che costituisce un corpo, della sua trasformazione ed incorporazione nella sostanza vivente di un altro organismo o della sua mineralizzazione. Il tempo necessario perché si verifichino questi fatti può essere anche molto lungo: dal corpo di un mammut sepolto nel permafrost o nei ghiacci della Siberia potrebbe forse venire estratto del materiale utilizzabile, con tecniche sofisticate, per la sua clonazione. Naturalmente non si può aspettare tanto e, allo stesso tempo, esigenze cogenti di natura igienica, antropologica, giuridica, sanitaria, impongono di stabilire un momento esatto - giorno, ora, minuto – per quell’evento. La morte è un processo che noi trasformiamo in un fenomeno istantaneo. Con criteri, arbitrari, anche se non irragionevoli. Ed è anche un sostantivo al quale, da qualche tempo, ci siamo abituati ad associare un aggettivo: morte biologica, morte clinica, morte cerebrale. Aggettivi ai quali la sempre più sofisticata tecnologia medica ne ha aggiunto uno nuovo: corticale.
La morte corticale, o stato vegetativo permanente, è la perdita, a causa di una grave lesione cerebrale, di tutte le funzioni nervose superiori: capacità psichica, consapevolezza di sé, capacità di provare dolore o sofferenza, di porsi in relazione anche minimale con gli altri e col mondo circostante mentre l’integrità del tronco encefalico consente la prosecuzione delle funzioni vegetative. Naturalmente incapace di compiere azioni volontarie questo corpo non può mangiare o bere e dev’essere alimentato mediante una sonda e idratato mediante infusioni liquide.
Lo stato vegetativo permanente può durare anni, decenni - vedansi i casi di Karen Quinlan negli Stati Uniti, di Tony Bland in Inghilterra, di Eluana Englaro in Italia – e pone l’importante questione se costoro possano considerarsi deceduti o non. Attualmente la legge considera vive queste persone e l’interruzione dei presidi terapeutici integrerebbe il reato di omicidio per eutanasia.
La morte come l’abbiamo sempre concepita sia pure nella diversità dei criteri adottati per definirla, è la cessazione dell’esistenza di una persona: sarà dunque la nostra idea di persona a definire la nostra opinione su questa materia. Coloro che concepiscono la persona come un’entità capace di attività psichica ed emozionale anche limitata, di porsi in relazione anche rudimentale col mondo circostante e con le persone che ne fanno parte, di provare barlumi di gioia, dolore, speranza, possono accettare la coincidenza di morte corticale con morte tout court e di fatto questa è la filosofia che ispira i movimenti che se ne fanno fautori: coloro che ritengono invece che la perdita di quelle facoltà non basti a togliere lo statuto di persona non potranno che respingere l’ipotesi di adozione dei caratteri dello stato vegetativo permanente come criterio di morte.
ACCANIMENTO TERAPEUTICO
E DISPOSIZIONI ANTICIPATE
Un atteggiamento eticamente rilevante è quello del cosiddetto accanimento terapeutico, una ostinazione nel porre in atto rimedi volti a prolungare un’esistenza giunta alla sua fase terminale, al di là di ogni ragionevole previsione di successo con il risultato di prolungare, con la vita, anche la sofferenza del malato. Esprimono contrarietà all’accanimento terapeutico tanto la bioetica laica che quella cattolica: quest’ultima, tuttavia, limita la propria critica ai presidi terapeutici “straordinari” ritenendo invece doverosi quelli “ordinari” ossia quelli volti a rispondere a necessità basilari come ad esempio la nutrizione e l’idratazione. La distinzione tra questi due tipi di intervento è, con tutta evidenza, molto ambigua e si presta a valutazioni anche molto diverse.
Il rifiuto delle cure, anche quelle “ordinarie”, è comunque una facoltà, un diritto che in Italia è garantito dalla Costituzione ed è particolarmente importante nella malattia terminale: tuttavia può accadere che, proprio in quelle circostanze, il malato non sia in condizione di esercitarlo a causa delle sue condizioni psichiche deteriorate. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, possono venir formulate delle direttive anticipate che avranno lo stesso valore di una volontà lucidamente espressa. Nel Living Will (“testamento biologico” come viene definito in italiano) il cittadino elenca i trattamenti ai quali non desidera essere sottoposto e nomina un fiduciario che garantisce l’applicazione della sua volontà. La Consulta Bioetica di Milano ha già formulato proposte di legge ed elaborato un modulo per la raccolta di queste direttive (biocard) qualora il parlamento elaborasse una legge sulla materia. Naturalmente non possono essere oggetto di direttive anticipate disposizioni che, nel nostro ordinamento, costituiscono reato, come l’eutanasia.
Per quanto riguarda i risvolti bioetici vale per le direttive anticipate ciò che vale per altre manifestazioni di volontà: la loro liceità dipende dal codice etico – sacralità o qualità della vita – al quale il cittadino ritiene di ottemperare.
L’EUTANASIA E IL SUICIDIO ASSISTITO
L’eutanasia, una pratica che in Italia costituisce reato, consiste nel procurare la morte di un malato al fine di sottrarlo a gravi e non evitabili sofferenze. Anche nei paesi in cui questa pratica è ammessa l’eutanasia deve venire espressamente richiesta dal soggetto: in caso contrario, tutti gli ordinamenti giuridici concordano nel ritenerla un puro e semplice omicidio al quale vengono tutt’al più riconosciute delle attenuanti. L’eutanasia di cui si parla è quella attiva: quella passiva, consistente nell’interruzione di provvedimenti essenziali per la sopravvivenza, ha confini assai mal definiti con l’interruzione di cure che costituirebbero accanimento terapeutico. Il suicidio assistito, ossia l’aiuto fornito al malato che desidera suicidarsi ma che si trova materialmente o psicologicamente nella difficoltà di compiere gli atti necessari a realizzarlo è sovrapponibile, sul piano etico, all’eutanasia attiva e la distinzione tra i due atti può avere un significato solo in ambito giuridico.
All’eutanasia vengono spesso assimilati gli atti che consistono, per usare una brutta ma diffusa espressione, nello “staccare la spina”, su esplicita richiesta del paziente, di apparecchi che lo tengono in vita. Questa assimilazione è del tutto impropria e costituisce semmai un diniego ad ottemperare alla richiesta di rifiuto delle cure: nessuno considererebbe infatti un atto eutanasico la mancata messa in atto di presidi terapeutici strumentali se questa fosse la richiesta. Perché dunque dovrebbe esserlo la loro interruzione, nelle stesse condizioni?
ALTRE QUESTIONI
Queste poche, sommarie considerazioni danno un’idea di quanti problemi ponga la moderna medicina all’etica, al diritto, alla politica. Ma il campo è ancora più vasto e va dalle responsabilità nei confronti della biosfera e dell’ambiente, che si continua a danneggiare, alla questione dell’allocazione delle risorse e degli investimenti finalizzati alla cura dell’uomo, dai diritti degli animali, all’etica della ricerca medica. Quest’ultimo argomento, anzi, è quello al quale si deve l’impulso alla riflessione bioetica dopo la seconda guerra mondiale, quando si scoprì, nel processo di Norimberga, che esperimenti medico-biologici crudeli quanto inutili erano stati parte non secondaria delle efferatezze naziste: Joseph Mengele non fu un caso isolato. Non si deve tuttavia pensare che una ricerca disumana sia stata appannaggio del solo nazismo se persino nei civili e democratici Stati Uniti hanno potuto verificarsi casi come l’esperimento di Tuskegee sulla sifilide in cui “seicento maschi neri, quattrocento dei quali affetti da sifilide, furono tenuti sotto controllo dal 1932 al 1972, senza che fossero sottoposti a terapia, per osservare il decorso naturale di tale malattia permanente e debilitante, sebbene negli anni Cinquanta fosse disponibile una cura efficace, la penicillina.” (2)
La riflessione bioetica, che affianca ed estende la deontologia medica negli ultimi anni ha ricevuto un grande impulso dallo sviluppo della tecnologia medica, è divenuta negli ultimi anni oggetto di interesse diffuso anche tra i non addetti ai lavori, come si suol dire, ed ha esercitato a sua volta uno stimolo importante per lo stesso pensiero giuridico che si è concretato, qua e là nel mondo, in provvedimenti legislativi a volte anche molto discussi. Molte questioni, nel nostro paese, giacciono ancora sul tavolo della politica dal quale è auspicabile che prendano il volo per una sempre più ampia tutela dell’uomo, della sua vita, della sua dignità.

|