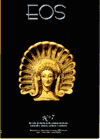|
Anno 3 - N. 9 / 2004
GABRIELE D’ANNUNZIO
“CON MILLE VOLTI E SENZA VOLTO ARRIDE A QUEL CHE VEDE E A QUEL CHE MAI NON VIDE”
Due amori meno noti
di Giulio Cesare Maggi

Elena Sangro "La Piacente" (in Maciste all'inferno" di Guido Brignone, 1926.
In quel dorato autunno romano del 1905, attorno al Vate – non ancora Veggente – si muoveva con grazia un’eletta schiera di splendide e adoranti dame dell’aristocrazia e della ricca borghesia della Capitale, invaghite fino alla follia di quel piccolo e stempiato quarantenne, tra le malcelate preoccupazioni di mariti e fidanzati.
Di quella provinciale e “beotica tardità” Gabriele D’Annunzio godeva – facendosene un po’ in cuor suo beffe – tutti i vantaggi: partecipava, invitatissimo e conteso ospite, a spettacoli teatrali, concerti, cacce alla volpe, a brillanti cene e serate mondane di quella città che solo da pochi lustri era diventata la Capitale del Regno e che era alla ricerca di una propria identità e di una dimensione almeno nazionale.
Si era imposto Gabriele D’Annunzio alla ammirata attrazione del pubblico, almeno di quello colto, attenzione che oramai sconfinava nel fanatismo, fin dalla giovane età con le poesie di Primo vere e poi con i romanzi, dal Piacere all’Innocente, che con i loro marcati spunti di morbosità, di “adesione ad un modello di vita inimitabile”, si avvicinavano alla teoria del Superuomo nietzsciano; egli aveva aperto un orizzonte di pruriginosa quanto appena dissimulata attrazione, fino ad allora sconosciuta alla moderna letteratura italiana, verso i misteri della sessualità, quale modo di essere, quale ars vivendi prima ancora che amandi.
Circondato da fama non usurpata di coureur de femmes di geniale estrosità, esteta e fruitore del sesso con quel certo distacco di cerebralità che aveva già evidenziato nei suoi romanzi, attraente e nel contempo un po’ temuto, Gabriele D’Annunzio fu in questo senso favorito forse dall’ondata di femminismo che stava dilagando in tutta l’Europa. Furono però soprattutto la sua relazione con la Duse e la sua straordinaria produzione teatrale drammatica di quel periodo di fine secolo, che resero quasi mitica la sua figura, specie nell’àmbito femminile: è un periodo che si prolungherà fino al 1908 e che porta i nomi dei suoi lavori teatrali quali La città morta, La Gioconda, La fiaccola sotto il moggio, ma anche poetici con Alcyone per citare solo qualcuno dei suoi grandi successi.
Il tempo diviso tra la Capponcina e la Capitale ne rendeva ancor più preziosa la frequentazione: tutto il bel mondo era in attesa di saperne di più, di venire a conoscenza almeno di una “favilla” di quella straordinaria ed inusuale e sicuramente inimitabile esistenza, di quel venturiero senza ventura, come poi volle far credere di sé in uno scritto largamente autobiografico: sembrerebbe in realtà di trovarsi di fronte ad una declinazione scaramantico-apotropaica, più che altro.
I suoi amori furono, per quanto è dato sapere, tempestosi e poco convinti: né poteva essere diversamente in virtù del suo temperamento lapideo ed al contempo ondivago, dalla Duse fino alla Baccara degli ultimi anni al Vittoriale.
Lunga è la lista del suo “catalogo” amoroso che ebbe il suo Leporello nel pur discreto Tom Antongini. Se ne è detto e scritto a sazietà e non meriterebbe insistervi ulteriormente: tanto più che molto fu amore “cerebrale”, nel quale l’Artista sovrastava l’Uomo, e perciò più di interesse letterario che umano, come si realizzò nei suoi romanzi, che regolarmente la Sacra Congregazione del Sant’Uffizio “calò nell’Indice dei proibiti” come ricorda Leonardo Sciascia. Voluttà dominante soprattutto, espressa in stilemi di straordinaria quanto, per allora nel Paese, inconsueta audacia e spregiudicatezza.
Tuttavia due di queste “storie amorose” furono per D’Annunzio di tale significazione da lasciare una traccia diremmo autonoma, non riconducibile perciò ad un “catalogo” sia pure contrassegnato da nomi (e fatti) quali quello di Eleonora Duse.
Entrambe queste due relazioni, delle quali si parlerà, cercando di porle, se possibile, a confronto nella loro intrinseca natura e nel ricordo che di esse lasciò D’Annunzio, si tradussero anche in due opere, il Solus ad Solam – uscito postumo nel 1939 a cura di Jolanda De Blasi – ed il Carmen Votivum, che ha come sottotitolo Alla Piacente, con il quale è più noto e che è del 1927.
Oggi D’Annunzio è un poco “passato di moda”, possibilmente da ignorare nella storia della letteratura italiana, e tutto ciò a dispetto dello straordinario ed inimitabile suo modo di porgere la parola scritta. Ma tant’è.
L’incontro con la donna del Solus ad Solam Giuseppina Mancini avvenne in modo del tutto casuale, ad una cena dopo Teatro verso la fine del 1905: egli le sedeva accanto a tavola. Lieve fu la conversazione con sorpresa di lei che temeva noioso il discorrere dell’uomo delle Muse. Egli, come ricorda per notizie di prima mano Jolanda De Blasi, giocava con piccoli dadi gemmati, a cifre e geroglifici, gettandoli sulla tavola: da questi il Poeta traeva “uno oroscopo pieno di misteri”. La bella dama, una contessa fiorentina, sposa ad un cospicuo produttore di vini, pur lusingata da queste eleganti ed ambigue attenzioni da parte del Vate, idolo del femminino romano e non solo, cercò di sottrarsi all’assedio amoroso, che subito percepì, con l’intuito tipico delle donne, possibilmente fatale.
Temeva infatti, e così fu, di cadere nelle braccia del non più giovane ma quanto attraente ammiratore. Il quale con cortesi biglietti, fiori e persino con dolci rari (ella era golosa!), con ogni sorta di amabili finezze quali il dono di due cuccioli del suo celebre allevamento di cani, mentre essa era a Salso, a Milano, a Firenze, manteneva viva la curiosità di lei. Le lettere, e le conosciamo, erano assai rispettose, chiuse da un devoto bacio delle mani alla “cara Contessa”.
La chiamerà poi Giusini “il suo profano e divino Arcangelo” Gabri.
Ed ecco il fatidico 11 febbraio 1907, la data che D’Annunzio ricorderà per tutta la vita, fino alla morte.
Quella lunga e difficile vigilia – comprensibile in una donna di saldi princìpi e di elevato ceto sociale – non trascorse senza che ella ne avesse risentito sotto il profilo emotivo, con marcati sensi di colpa per un peccato non ancora commesso. Fu quella data l’inizio di una felicità tormentata e tormentosa: “la felicità è forse conquistata, la pace è certo perduta” commenta convinta Jolanda De Blasi nella prefazione, di chiaro gusto dannunziano, allo scritto (G. D’Annunzio, Solus ad Solam, Firenze, Sansoni, 1939).
Anche ne Le faville del maglio vi sono larghe anticipazioni del testo definitivo scritte in quello che egli chiamava A.G. – anno di grazia – 1907, testo nel quale si può già cogliere una sincera ispirazione umana più che solamente artistica: e non si può non pensare che questo sia il risultato di un amore vero, forse il primo e l’unico di Gabriele, vissuto senza che la cerebralità ne abbia parte alcuna, senza nulla di morboso.
Ma l’anno di grazia diventò per i due amanti un annus horribilis. L’apparente iniziale indifferenza del marito di lei, si trasformerà in una vera persecuzione, cui partecipò il gruppo familiare, padre in testa. Lo scandalo divampò a Firenze e poi a Roma: se ne parlava nei salotti e la inscia turba se ne impossessò. Le fu concesso il ritorno in famiglia, dopo un lungo periodo nel quale la povera Giusini, forse già emotivamente provata, cadde in uno stato di insanie, una vera “catastrofe”, un episodio psicotico vero e proprio, con fenomeni di delirio e confabulazione.
È in questo periodo “orribile” che D’Annunzio inizia la stesura del Solus ad Solam (10 settembre 1908): la chiuderà il 5 ottobre “Quando l’amarezza mi soffocò”. Il giorno prima aveva notato: “Anche questa è una vigilia. Non so perché sento che debbo ancora salire nel dolore… Il domani ha un volto di carnefice spietato”.
Al manoscritto fa subito seguito il frontespizio del Roman de Tristan et Iseut con la notazione di suo pugno in langue d’oïl: Bela amie, si est de nous: ne vous sans mei, ne je sans vous. E in una pagina del dolente diario “Tutto qui è detto con l’anima nuda. E v’è un testimone leale della mia sincerità, il dottore”. Era il Dr. Nesti, curante di Giusini e per Gabriele lo ?????, il Nuncius, “colui che sa”. Di lui si sono ritrovate le lettere che testimoniano dell’angoscia, dello strazio del Poeta: ma fors’anche di un senso di colpa da espiare, un sentimento nuovo per il Vate, un tormento reale, non di maniera.
Da questo calvario la povera Giusini uscì solo con il tempo, riammessa poi con fatica e sotto la tutela, non solo psicologica, da parte del clan.
Il Dr. Nesti non fu il solo testimone dello stato d’animo di Gabriele: la poetessa czeca Maria V. – che aveva tradotto per D’Annunzio La Nave – potrà raccogliere dal Poeta testimonianze sulla tragedia dei due amanti, su quello che sarebbe assai riduttivo, nonché ingiusto, classificare come un episodio della vita amorosa del Vate o, peggio, un numero del “catalogo”.
L’11 febbraio 1938 – sempre questo giorno e questo mese fatali ! – poco prima di morire, le scriveva: “Oh, ricordi dolci e laceranti!… e fu l’ultima mia felicità”: erano trascorsi trent’anni. Fu realmente, v’è da crederlo, un amour-passion.
Quel difetto di umanità che si riscontra spesso nei suoi romanzi nei riguardi del sentimento amoroso, al quale sovente si sostituisce la cerebralità e non raramente il morboso, cede il passo nel Solus ad Solam a tutt’altre corde, a tutt’altre fibre, ad una pietas in D’Annunzio veramente singolare.
Solus ad Solam rappresenta in D’Annunzio, secondo alcuni, un unicum umano e letterario per la presenza del dolore che colpisce l’Uomo prima del Poeta: non più sensualità o cerebralità quindi ma sensibilità.
Già nel corso della malattia dell’amata aveva scritto “Vi sono al mondo delle cose peggiori della morte”: parole e pagine d’amore che non hanno riscontro nella pur ricchissima prosa dannunziana. Anni dopo le scriveva “sei sempre rimasta nel mio cuore”, invitandola a raggiungerlo per qualche giorno al Vittoriale, offrendole un’ospitalità “regale”, peraltro non accettata.
Del resto alla donna del cuore aveva dato anche il nome di Amaranta, colei che non appassisce mai (??-???????).
Nel 1931 Gabriele D’Annunzio faceva stampare in facsimile (Verona, Mondadori, 1931) un volumetto scritto nel 1927 dal titolo Carmen Votivum.
L’anno successivo, ad opera di Leo Valli uscì un’edizione in 19 esemplari, stampata su 42 carte da gioco, per bibliofili selezionati, verosimilmente non autorizzata dal Poeta. Nel 1935 egli includeva lo scritto nelle Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele D’Annunzio tentato di morire (Verona, Mondadori, 1935), poi nell’Opera Omnia comparsa lo stesso anno.
Disponiamo oggi anche dell’edizione anastatica, dal titolo Alla Piacente (Milano, Bompiani, 1988) con una gustosa presentazione di Leonardo Sciascia, il quale ne parla come di uno scritto dannunziano da porsi tra i lepidi e lascivi.
Alla domanda che D’Annunzio rivolge a se stesso “Perché scrissi con un impeto giovanile e con un’ironia sottile, la Tenzone tra il Triangolo ed il Circolo ?” dà risposta Sciascia – e credo sia nel vero – “per rivivere nella inane “turpe” vecchiaia […] quei momenti di splendore erotico, quegli sprazzi di voluttà”. E lo teneva tra i livres de chevet con pochi altri tra i quali Les fleurs du mal di Baudelaire.
Il manoscritto originale del Carmen Votivum, regalato da D’Annunzio alla Musa ispiratrice, finì all’asta e se ne sono perdute le tracce: fortunatamente era già stato riprodotto in copia anastatica da Mondadori che lo custodì fino alla pubblicazione.
Ma chi era la Piacente?
Si chiamava Maria Antonietta Bartoli Avveduti, giovanissima attrice del nascente cinema italiano, con nome d’arte Elena Sangro, forse – ma non è per nulla certo – suggerito da D’Annunzio: il nome d’arte era in ogni caso di “conio dannunziano”. L’Immaginifico era creatore di nomi fortunati, ad esempio quello di “La Rinascente” dato ai Magazzini Bocconi di Milano che erano andati a fuoco: per il nome il poeta fu ricompensato con lire italiane cinquemila, cifra per l’epoca cospicua.
Elena Sangro era donna estremamente avvenente secondo i canoni fin de siècle Novecento ineunte, come è possibile vedere dagli spezzoni dei film giunti fino a noi, film che la vedevano quale protagonista incontrastata.
Per alcuni di questi film, come ad esempio Non c’è resurrezione senza morte del 1922, D’Annunzio, quale Presidente del Comitato Montenegrino, produttore del film, fu il regista occulto assieme al figlio Gabriellino. Questa volta, con scarsa fantasia, Elena fu ribattezzata da lui Ornella. Gabriele conobbe la stupenda donna, poco più che ventenne, probabilmente sul set.
Nessun patema d’animo, nessun senso di colpa questa volta, nulla di cerebrale forse neppure nulla di umano che non fosse pura sensualità, caratterizzò la loro relazione, scandita al più da reciproci impegni dei due amanti.
Solo nel 1927 ella soggiornò a lungo al Vittoriale presso il suo adorato Ariel.
Il quale, secondo opinioni basate su riscontri anche filologici, non scrisse il Carmen di getto: esso fu pubblicato dapprima, come si è detto, nel Libro segreto anche per qualche pressione dell’Editore, con successivo immancabile inserimento nei libri all’Indice.
Mussolini, già seccato per l’edizione del 1927, comparsa in un momento nel quale iniziavano gli approcci tra Stato e Vaticano in vista della auspicata Conciliazione, rispose con un secco telegramma all’invio da parte di D’Annunzio di una copia con dedica del Carmen. Oltretutto la povera Elena Sangro, resa oggetto di pubblica e certificata curiosità, si sentì esposta nel corpo e nell’anima alla pubblica e pruriginosa attenzione di tutto il Paese.
Tuttavia, spinta forse dalla necessità, con dubbio gusto cercò di crearsi il ruolo di un’Afrodite nei riguardi del suo Pigmalione.
Del voluttuoso rapporto tra Ariel ed Ornella resta a noi quale testimonianza il Carmen Votivum: il poemetto, in 22 sestine per un totale di 132 versi, porta all’inizio l’indicazione ??? ????????? (Alla Piacente) e subito dopo… ????? ???? ???????? (ma tutto bisogna osare).
Viene qui in mente il bellicoso incitamento Memento Audere Semper, anche se queste battaglie sono quelle dell’alcova… Si tratta in realtà di un frammento di un’ode saffica, e perciò di tutt’altro indirizzo.
Il poemetto stilla di intensa voluttà, in forme che la grecità, una certa grecità, avrebbe affrontato con maggior levità.Vediamo qui, ad esempio, la terza sestina:
“Piacente sopra te, quanto mi piaci!
Assai più d’ogni frutto e d’ogni fiore,
assai più d’ogni fonte. ne’ tuoi baci
la musica ed il silenzio del sapore
s’avvicendan così che tu m’insegni
l’arte dell’ape ne’ suoi favi pregni”.
E dice ancora Ariel:
“Nella mia greca mente Euclide stesso
tra circolo e triangolo è perplesso”.
Ma la grecità non è certo l’unica fonte di ispirazione del Poeta, come si può vedere dai versi che seguono, dell’antico Signore di Lucca, Ser Bonagiunta Orbic(c)iani:
“Vostra piacenza tien più di piacere
d’altra piacente, però mi piacete”.
E il poemetto si chiude con
“Sviene l’alba. ti piaccia Helene,
immortalarla in grembo all’altra Aurora”.
Come si vede non proprio cose da educande.
Tra periodici entusiasmi e improvvisi raggelamenti la povera Elena-Ornella si vide messa alla porta al Vittoriale essendosi presentata senza il placet preventivo del Vate: incombeva già la Baccara, mentre Ariel si avviava ad un “turpe” vecchiezza, che ne accentuava le asprezze del carattere e del comportamento.
Tra i due eventi ed i lettori d’oggi è passato gran tempo, almeno per la maggioranza di essi, ed il clima culturale e di costume dell’epoca è troppo distante dall’attuale: oggi si scrive e si legge, osserva argutamente Leonardo Sciascia, ben altro, “in ben altre cantine si è bevuto”, ma eravamo negli Anni Trenta!
Stupet inscia turba scriveva D’Annunzio in epigrafe al Carmen Votivum, e non si sbagliava: uniamoci al giudizio del Vate, ora già Veggente.
Di Eros che si fa eleganza lasciamo ai letterati lo studio e la cura.
Noi accontentiamoci di ricordare queste due declinazioni offerte dall’eros dannunziano: per certo due visioni completamente diverse, forse antitetiche, del rapporto amoroso, non solo per gli accadimenti differenti che li caratterizzano: una visione quella del Solus ad Solam, sublimata dal dolore che attraverserà tutta la vita di Gabriele, fino alla morte. L’altra, e lo dice già l’indicazione Alla Piacente, permeata, intrisa di voluttà senza riserve, il cui ricordo è più di desiderio rinnovato, forse solo un gioco più che altro, gustoso ma senza una vera traccia, che riceverà il suo stigma esemplare proprio nella edizione su carte da gioco prima ricordata.
Preme qui a chi scrive, nel congedare questo contributo su due amori di un D’Annunzio meno noto, che godono di una “documentazione” di prima mano, sottolineare la sostanziale, ed in certa misura sorprendente, differenza tra due svelamenti del suo eros, l’uno tragico che durerà tutta la vita del Poeta e l’altro esclusiva rappresentazione della voluttà, forse rappresentativo, quest’ultimo, per alcuni aspetti, come è stato detto, dell’intero opus dannunziano: questo giudizio a maggior ragione ci fa considerare Solus ad Solam un unicum nella vita e nell’opera sua, l’unica epifania dell’unico solo suo amore.

|